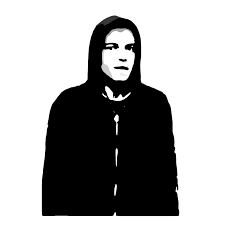Premessa
In Gran Bretagna nel 1811 alcuni strani figuri (capitanati da un fantomatico capobanda di nome Ned Ludd) iniziano a distruggere sistematicamente le nuove macchine industriali, che abbassavano il costo del lavoro aumentando in un sol colpo mole e velocità di produzione.
Il 12 aprile 1811 trecentocinquanta uomini, donne e bambini attaccano una fabbrica di filati nel Nottinghamshire, distruggendo un gran numero di macchine appartenenti all’importante manifatturiere William Cartwright. La rivolta luddista non si limita ai telai: si estende alle nuove macchine per tosare, ai nuovi mulini impiegati in campo tessile, spandendosi rapidamente per tutta l’Inghilterra centrale e settentrionale. Quel che pare certo è che i luddisti abbiano avvertito in modo chiaro e maturo che l’avvento delle macchine (dei telai industriali) aveva come scopo fondamentale quello di muovere guerra alla loro specifica forma di vita e di lavoro. Il telaio meccanico inizialmente era in grado di produrre solo tessuti scadenti destinati all’esportazione; in compenso esso si rivelò da subito una pedina tattica fondamentale del progetto capitalista di modellaggio e disciplinamento della nascente classe operaia britannica. Un progetto di “cattura” che stava prendendo piede a differenti livelli strategici. Non a caso siamo nello stesso periodo in cui si costruiscono le prime città operaie sorvegliate; lo stesso periodo in cui, per intervento del Signor Colquhoun – e del suo aurorale Trattato sulla Polizia della metropoli del 1790 – milizie private di fanatici, invasati protettori della morale pubblica vengono progressivamente integrati dal potere costituito fino a divenire rapidamente, e un po’ magicamente, niente meno che la polizia cittadina di Sua Maestà. Spoiler: la polizia come la intendiamo noi nasce solo due secoli fa con lo Stato borghese.
Una polizia che, come nota Foucault ne La società punitiva, nasce fin dall’inizio con lo scopo di 1) Moralizzare vizi e piccoli illegalismi della nascente classe operaia. 2) Reprimere sul nascere ogni possibile manifestazione di rivolta e malcontento. Manca d’altronde solo qualche decina d’anni al momento in cui la nascente psichiatria e il nascente romanzo borghesi si serviranno della teoria della degenerazione per patologizzare proletariato e vecchia nobiltà, ponendo finalmente la nuova classe borghese in ascesa come misura di tutte le cose, salute mentale inclusa.
Odiati da destra e da sinistra, chimera degli storici (Marx compreso)
Ma chi erano davvero i luddisti? Gli storici liberali li considerano ovviamente dei bruti, mentre la storia marxista ha spesso considerato il movimento luddista come indegno di appartenere alla dialettica storica tra capitale e classe operaia. Marx in persona ha visto infatti nel luddismo una strategia tipica dei socialismi cosiddetti pre-scientifici (ossia pre-marxisti: quelli che, fin dai tempi della sua querelle con Proudhon, definisce un po’ superficialmente “ingenui” ). Marx però qui si sbaglia. La smania di distinguersi troppo rapidamente e troppo nettamente dai molti lottatori sociali che lo hanno preceduto, non sempre gli ha consentito di guardare con la giusta lucidità storica al suo passato più prossimo.
Altri storici, come il contemporaneo Edward Thompson (in The Making of the English Working Class, del 1963), ritengono invece il luddismo una tappa importante – concreta, reale – della protostoria della classe operaia. I luddisti sarebbero, sotto quest’altra prospettiva, una preziosa istantanea storica scattata di soppiatto a una delle tante strade che la lotta operaia avrebbe potuto prendere – e non ha preso.
Una strada che non di meno rimane aperta per noi. Marx accusa i luddisti di non capire che la macchina in sé non è malvagia, ma un pharmakon. Una doppia lama capace potenzialmente un giorno di trasformarsi da bestia nera in più prezioso alleato della classe operaia. Noi però, con i luddisti, potremmo rispondere a Marx che non tutte le macchine hanno questa doppia faccia. Non tutte le macchine sono potenzialmente “buone”, e sopratutto non tutte le macchine sono potenzialmente “buone” per gli sfruttati. Non ogni sviluppo produce necessariamente conseguenze positive, non tutte le invenzioni tecnologiche che discendono da un certo progresso tecnologico fanno bene all’essere umano (l’esempio più eclatante è senza’altro la bomba atomica). Chi ha ragione allora, Marx o Ludd?
Due rivoluzioni tecnologico/industriali a confronto
Con i luddisti noi oggi condividiamo il fatto di fronteggiare trasformazioni tecnologiche epocali. Come i luddisti siamo una generazione “di transizione”, presa nel mezzo di un cambiamento di paradigma tecnologico che investe per intero il mondo del lavoro e della produzione. È per questa ragione che lo sguardo che i luddisti potevano gettare sui primi effetti della “loro” rivoluzione tecno-industriale può esserci molto utile a livello strategico.
Michel Barillon, nel suo bell’articolo Sguardi incrociati sui luddisti ed altri distruttori di macchine – uscito su “Ecologie & politique” n°37 2008/3 – rileva acutamente che la generazione di operai successiva ai luddisti (Marx compreso), nascendoci dentro, troverà già la vita di fabbrica come qualcosa di normale. La generazione successiva ai luddisti troverà già normale “servire” la macchina per sopravvivere, come per fortuna troverà normale ribellarvisi. Eppure – e questo è il punto di Barillon, questa generazione successiva già non ricorda, non sa più come fosse, la vita prima delle macchine se non per mezzo di racconti, scritti, canzoni. Allo stesso modo, diversamente da me, mia figlia trova già normale comprare su Amazon, scrivere continuamente su WhatsApp, usare il telefono come un’estensione della sua persona o subire la didattica a distanza. Come la generazione successiva ai primi luddisti, anche mia figlia tende ad avere meno consapevolezza della violenza e dell’alienazione che si celano in tutte queste nuove normalità. Così, mentre io vomiterei dopo tre ore di fronte al computer, probabilmente per lei sarà del tutto normale lavorarne anche otto ininterrottamente. Allo stesso modo, la generazione successiva a quella dei luddisti, cioè quella di Marx, considerava già la macchina come un dato di fatto non rinegoziabile: il suo obiettivo è stato quello di impadronirsene (la famosa collettivizzazione degli altrettanto famosi mezzi di produzione). Tutto ciò nascondeva però un non piccolo errore di prospettiva: i mezzi di produzione (intendo proprio il modo in cui sono pensati e costruiti), come lo Stato e i suoi vari Apparati, non sono affatto neutri: sono piuttosto la quintessenza, l’incarnazione stessa, dell’ideologia capitalista. Come accadde ai romani con i greci, impadronirsi di istituzioni così radicate e capillari rischia di coincidere con il “lasciarsene conquistare”. Graecia capta ferum victorem cepit. Un altro esempio è la Russia, la patria del socialismo che – dopo aver cercato di competere per mezzo secolo con gli USA dal punto di vista della produzione – è finita per non desiderare altro che il capitalismo. La crisi dell’Unione Sovietica ha dimostrato che scimmiottare la produzione capitalista (in salsa statale) non potrà mai bastare per “salvare” una rivoluzione comunista. Paradossalmente, anche se non avrebbero mai potuto nemmeno esistere senza la potenza economico-industriale dell’URSS, da questo punto di vista Cuba e Cina sono state molto più accorte. In Cina infatti il processo di industrializzazione inizia appena dopo Mao, alla fine degli Anni Settanta, con Deng Xiao Ping; come non credo serva insistere sull’antipatia di Cuba e di Fidel per lo sviluppo incontrollato di industria e tecnologia.
L’uomo si abitua a tutto, ma è proprio per questo motivo che bisogna agire mentre un paradigma sta cambiando. Quella contro la tecnologia dello sfruttamento è la nostra battaglia. Dopo di noi la porta si chiuderà, tra sessant’anni non ci sarà più una persona al mondo – nemmeno in Africa – ad aver conosciuto un tempo senza smartphone.
Se ci caliamo per un attimo nei loro panni, non possiamo non solidarizzare con i luddisti. Essi hanno riconosciuto nitidamente nelle nuove macchine uno strumento scientemente architettato dai padroni per togliere loro potere contrattuale. I luddisti hanno “capito” immediatamente le macchine; hanno sentito istintivamente cosa sarebbero diventate di lì a poco: lo strumento disciplinare e alienante per definizione attraverso cui la nuova classe dominante avrebbe omologato culturalmente (a livello di consumi), livellato al ribasso (a livello di salari) e schiavizzato (a livello pratico e ideologico) l’intera classe operaia inglese.
Sarà solo il fatto di possedere un impero coloniale a salvare l’Inghilterra capitalista dalle rivolte operaie. Le Trade Unions infatti, molto prima degli altri movimenti europei, avranno quello che vogliono: i padroni concederanno loro quasi subito alcune briciole, in virtù dell’immensa fortuna che andavano ingrassando grazie al colonialismo imperialista.
Di chi è l’errore di prospettiva?
Ci si potrebbe chiedere insomma, tornando ai luddisti, di chi sia stato davvero l’errore di prospettiva nei confronti della prima rivoluzione tecnologica: loro o di Marx? E venendo a noi e all’odierno dibattito tra tecnofobi e tecno-entusiasti, cosa ci impedisce di chiederci seriamente se non sia il caso di distruggere, finché siamo in tempo, tutte le macchine che oggi producono solo sfruttamento e nessun bene sociale? E ancora, cosa ci impedisce almeno di immaginare che, dopo questo olocausto di macchine, potremmo rendere quelle che restano un bene pubblico inalienabile, in modo che nessun uomo, possedendole in proprio, possa disporre di un così smisurato potere sui propri simili? Utopie? Vedremo.
Ma Andrea vuoi dire che dovremmo fare a meno del cellulare, del computer, dell’automobile? No, vecchio mio, voglio dire che dovremmo “sacrificare” – alias distruggere – le macchine che generano sfruttamento, dipendenza e bisogni indotti. Un esempio: parlare con un affetto lontano è un bisogno sociale chiaro, indiscusso; farlo mentre lo vedi in video, francamente, no. Vedere l’altra persona in video quando senti come sta non è altro che l’upgrade di un bisogno sociale indiscutibile e, come tale, è un bisogno indotto.
I cellulari di vecchia generazione servivano a comunicare in un senso ancora del tutto tradizionale (chiamarsi o mandarsi un pizzino/telegramma – vedi sms), un modo in fondo non troppo diverso dal telefono dei primi del Novecento o dal telegrafo. L’unico di più stava nella sua “portabilità”. Lo scopo dell’esistenza sul mercato di uno smartphone invece, evidentemente, non è affatto quello di permettere alle persone di “comunicare”. Uno smartphone è “utile” (ormai quasi “essenziale”) solo nel momento in cui, esistendo, il capitale lo rende indispensabile per vivere e per lavorare.
Ricordo ancora come, già alcuni anni fa, una bizzarra preside sostenesse che non potevo lavorare in una scuola pubblica senza averne uno mio.
Uno smartphone – esattamente come la macchina a vapore aumentava la quantità e abbassava la qualità dei tessuti – serve solo ad aumentare la quantità (e ad abbassare la qualità) dei nostri rapporti umani. Punto. No, non c’è un modo virtuoso di concepire il mezzo e bla bla bla. Il diffondersi di questa tecnologia (lo sfruttamento che le sta dietro e a cui tutti contribuiamo) produce il peggioramento della qualità dei nostri rapporti umani, li smaterializza, ne fa uno strumento privilegiato di controllo della popolazione da parte dei grandi capitali – vedi big data, Facebook, Google, ecc. La rivoluzione hi-tech – complice anche il livello sempre più raffinato di capacità repressiva degli Stati neoliberali – è finora l’unica rivoluzione tecno-ideologica capitalista a non aver ancora generato una violenta reazione da parte di coloro che ne sono il bersaglio.
Four di provocazione
Non si tratta di passatismo, di dire che stavamo meglio quando stavamo peggio e che la cosa più bella era quando nelle caverne riproducevamo i suoni della natura per fare musica. Si tratta di operare una distinzione sottile, profondamente osteggiata dal ributtante binarismo a cui vorrebbero incatenarci i discorsi dominanti della nostra cultura. Il punto è che la macchina non è un pharmakon: è semplicemente un prodotto umano che genera trasformazioni sociali. Queste trasformazioni possono essere buone o cattive per i lavoratori (di solito sono cattive); ma ancora più a monte e a ben vedere, anche le trasformazioni “buone” per la socialità e la salute dei lavoratori non si producono se non nelle perdita, nell’entropia, nella trasformazione e nel sacrificio di una qualche pratica umana che già era un “bene”.
Esempio: pensiamo alla storia delle modalità di produzione e divulgazione della musica negli ultimi centocinquanta anni. Come negare la “bontà” del fatto che oggi posso ascoltare/fruire qualsiasi canzone senza pagare una lira? Tutto questo è meraviglioso, è il lato “buono” della macchina – e fin qui non ci piove. Ma come non vedere al contempo che questo bene, questa democratizzazione reale della fruizione della musica, ne ha cancellato (in modo molto meno percepito) un altro? Come non vedere che la maggiore possibilità di fruizione della musica generata dalla macchine (dal grammofono a youtube), ha indiscutibilmente disincentivato le persone a saper suonare e cantare? Centocinquant’anni fa, sopratutto tra il popolo che non poteva permettersi concerti e musica dal vivo, una persona su due sapeva suonare o cantare, anche se certamente meno bene rispetto a quelli che sanno farlo oggi. Io stesso, prima di avere uno smartphone, ho imparato a cantare perché mi annoiavo nella mia torretta di bagnino tutto il giorno a far niente.
Ecco che allora, per ogni democratizzazione prodotta dalle macchine, da qualche altra parte si consuma parallelamente, non vista, la de-democratizzazione di un qualche altro bene di cui già l’umanità serva e lavoratrice godeva. La questione interessa più in generale la passività cui la macchina strutturalmente induce l’essere umano – a tutti i livelli. Possiamo calare questo discorso anche a livello della scrittura, della produzione culturale: un tempo se non trovavi il libro che ti piaceva, dovevi scriverlo tu; oggi è quasi impossibile trovare qualcosa – da fare o da dire – che qualcun altro non abbia già fatto o pensato al tuo posto. Infatti hanno già trovato un modo per dire anche questo: lo chiamano information overload. O ancora, possiamo pensare al fatto che lettura e scrittura, per la stragrande maggioranza dei giovani di oggi, sono pratiche obbligate, desuete, noiose, che non possono competere con la facilità di fruizione e l’immediatezza di espressione incentivate dal mondo del web, dei video, delle immagini, dei meme. Si obietterà che oggi sono molti di più gli artisti che riescono a farsi conoscere e apprezzare grazie alla produzione e alla diffusione più “casalinghe” consentite da youtube o spotify. Ma io non sto parlando della diffusione dei propri “prodotti”, io sto parlando di questa necessità di fare, di essere attivi, di un bisogno quasi fisico di essere più attori (magari anche scarsi) che fruitori: è questo il “bene” che abbiamo perduto (e continuiamo a perdere) mentre guadagnavamo quell’altro. Non c’è dubbio che il web abbia aiutato la diffusione online di musica alternativa, eppure non è solo una contingenza storica il fatto che questo fenomeno sia andato in parallelo con la distruzione di tutte quelle micro-situazioni reali di musica “live” in cui le piccole band alternative suonavano alla feste del paese o nel baraccio sotto casa. Ne’ è un caso che la diffusione online della musica alternativa abbia offerto al mainstream un’ottima scusa per cancellarla completamente dai propri palinsesti.
In questo senso andrebbero forse ironicamente rivalutati, o almeno perdonati, complottisti e leoni da tastiera varii: seppur sintomaticamente, in fondo, sono persone che rivendicano il diritto di “dire” in un luogo (il web) che in origine aveva immaginato se stesso come la patria del libero pensiero. Da questo punto di vista il complottista non è molto diverso dall’ubriacone dell’osteria sottocasa di cui da ragazzo ascoltavi le storie assurde sprofondato in un’agrodolce miscela di ammirazione e compatimento. Forse bisognerebbe chiedersi il vero motivo della vera e propria crociata mediatica in atto contro questo tipo umano, … Ma lasciamo cadere.
Non si tratta di dire meglio questo (il mondo iper-tecnologico di oggi), o meglio quest’altro (il fermo-immagine di un qualche mondo utopico e irrealistico, fermato idealisticamente a un’immaginaria età dell’oro pre-tecnologica). Si tratta di cominciare seriamente a vedere questa oscillazione, ad abitare lo scarto tra ciò che guadagniamo e ciò che effettivamente, entropicamente, perdiamo a ogni singolo passo del notro presunto “progresso”. Si tratta di trovare un qualche godimento nell’esercizio critico di confrontare senza sosta il bene che guadagniamo grazie alla tecnologia con il bene che, sempre grazie a essa (e troppo spesso quasi senza accorgercene), perdiamo irrimediabilmente .
Che tipo di operaio era un luddista?
Il luddista erano un tipo di operaio un po’ particolare (che a dire il vero nel nostro Paese è sempre andato per la maggiore); un tipo di operaio tornato di moda anche “grazie” alla gig economy.
I luddisti erano ciò che oggi definiremmo “piccolissimi imprenditori”: operai autonomi. Artigiani che lavoravano da casa e su commissione, vendendo ai grandi manifatturieri i propri prodotti (tessuti grezzi) a un prezzo pattuito. All’interno di questa dinamica plurisecolare, l’avvento delle macchine sposta gli equilibri e costringe i luddisti a un tremendo doppio vincolo: o accettare di trasformarsi in operai di fabbrica tout court, o sopportare l’inarrestabile crollo del costo del loro lavoro autonomo (effetto della maggiore competitività delle macchine). Un aut aut veramente troppo amaro, che i luddisti rigetteranno preferendo la via della rivolta.
Da questa angolazione capiamo forse un po’ meglio la poca simpatia di Marx per queste figure di mezzo della Storia: si trattava in sostanza di lavoratori semi-autonomi e, per di più, decisamente conservatori quanto a costumi (spesso maschilisti e popolani, a volte vicini a sette religiose metodiste o levellers). Molti tra loro lamentavano il fatto che le nuove macchine consentissero anche a donne e bambini di lavorare. Un discorso attraverso cui intendevano forse proteggere le proprie donne e i propri bambini da uno sfruttamento di fabbrica che le nuove macchine stavano rendendo sempre più intensivo. Tout se tient.
Si potrebbe aprire una grande parentesi sulle trappole attraverso cui il capitalismo ha spacciato per emancipazione civile, femminile o razziale il raffinato e inesorabile allargamento delle maglie del suo cieco sfruttamento. Ricordo en passant che siamo lontani ancora cent’anni dalla prima Convenzione Internazionale (1919) che condannerà il lavoro minorile sotto i quattordici anni.
Un anello della catena sociale che andava spezzato
È in questo modo che fin dagli albori del capitalismo la grande proprietà persegue l’obiettivo specifico di fomentare la “guerra tra poveri” – in particolare attraverso i propri rapporti commerciali transnazionali/globali e con il suo costante entusiasmo per la guerra fatta rigorosamente a casa degli altri (nota bene, il luddismo si consuma durante le Guerre Napoleoniche). I luddisti hanno perso la loro battaglia perché sono stati demonizzati come folli e primitivi distruttori (che non erano affatto, poiché erano operai specializzati con un preciso – e intelligente – intento politico). Sono stati repressi con un dispiegamento di forze militari degno di una vera e propria guerra – si dice addirittura simile a quello impegnato nello stesso periodo contro Napoleone. Ma sopratutto, i luddisti hanno perso perché erano l’anello di congiunzione di una precedente gerarchia. I luddisti, proprio per la loro peculiare condizione di operai-autonomi, erano il trait d’union tra operai e piccola impresa che andava spezzato a ogni costo. A che scopo? Per poter separare nettamente la classe dominante da quella dominata nel nuovo mondo del Capitale. I luddisti erano il fastidioso brusio di fondo di una cultura plurisecolare che non andava più bene al nuovo potere, a un potere che proprio non riusciva a capire come ricollocarli. Con una battuta si potrebbe dire che sono stati i kulaki del capitalismo (o i borgatari e proletari di cui Pasolini ha disperatamente denunciato la forzata “mutazione antropologica”). Il nuovo potere aveva infatti la necessità di cronometrare gli operai nelle fabbriche, di sorvegliarli nelle città operaie; aveva bisogno di far controllare i propri “schiavi” a vista dalla nascente polizia inizialmente semi-privata e d’ispirazione religiosa; necessitava di identificare e gerarchizzare in modo chiaro le piccole e medie imprese sul territorio, per poter esercitare su di esse il suo nuovo ruolo egemone e di monopolio.
Luddisti di ieri, e di oggi?
Spero di aver mostrato fino a che punto il parallelo tra noi e i luddisti sia tutt’altro che campato in aria. Da una dozzina d’anni siamo dentro una vertiginosa ri-proletarizzazzione del popolo italiano ed europeo, che interessa sopratutto i lavoratori dipendenti privati e quelli della piccola e piccolissima impresa. Lavoratori che stanno venendo letteralmente affamati dalla nuova crisi-Covid e che hanno visto visto negli ultimi anni precipitare verticalmente le proprie condizioni di vita.
“Ma Andrea mica è colpa delle macchine, che c’entra!?”. E invece sì, caro mio, è proprio colpa delle macchine. Se la grande produzione ha potuto soppiantare la vendita al dettaglio è grazie alle macchine. È grazie alle macchine che persone economicamente allo sbando si lasciano sfruttare per cinque euro reali all’ora, producendo merci troppo competitive per un artigiano. Un meme tragicomico di un piccolo commerciante che gira su Facebook dice: “Tutti a comprare da Amazon, ma poi i curriculum li portate in negozio”.
È grazie alle macchine (le famose piattaforme di delivery) che il povero vecchio porta pizze si è trasformato nel giro di un decennio in uno schiavo sottopagato e digitalmente controllato a ogni metro del suo spostamento. Per non parlare degli insegnanti (e dei poveri studenti) in “didattica a distanza”, costretti giorno dopo giorno a vedere quel po’ di fiducia e di comunità tanto faticosamente costruite negli anni, infrangersi contro uno schermo. Possibile che a nessuno sia venuto in mente un altro modo? Possibile che la nostra furia tecnologica ci faccia apparire la didattica digitale l’unica soluzione concepibile? Non era meglio ridurre ancora più drasticamente i programmi ministeriali e fare lezioni a turno con gruppi di cinque/sette persone? Ah ma no, giusto, certo, si sarebbe dovuto spendere più soldi – gli stessi soldi che misteriosamente per altre “priorità” sono spesi senza batter cigilo (vedi F35 e nuovi “aerei spia”). Qui sono già sul limite del negazionismo per qualcuno, mea culpa.
Nessuno si è stupito che fino alla crisi-Covid paresse letteralmente impossibile investire pubblicamente in sanità e scuola (a causa del nostro mostruoso debito), e che poi magicamente per far fronte alla crisi, che è una crisi del sistema sanitario, non dimentichiamocelo, questi soldi sono stati trovati? Sarebbe stato sufficiente impiegarli prima e meglio questi soldi (come altri Paesi), per avere una scuola e una sanità all’altezza della nostra Costituzione e di eventuali emergenze. Questa è, a mio parere, l’amara verità che mass-media e governo temono diventi moneta corrente tra le persone. E infine, come non notare la troppo rapida e serena rassegnazione con cui molte persone di cultura (soprattutto quelle più attempate), hanno accettato di fare le loro comparsate “da remoto”, ognuno sui propri schermi e ben chiuso in casa sua?
Ma come negarsi in questi giorni il pensiero “stupendo” che – se fossimo stati liberi dal fanatismo tecnologico da cui siamo invece letteralmente posseduti – avremmo certamente concepito soluzioni diverse per far fronte a questa emergenza? Come non vedere che le macchine (che consentono la DAD), servono allo Stato per non disinvestire (ad esempio) sugli F35? Come non vedere che, ancora una volta, la macchina serve per risparmiare su ciò che di più umano c’è nell’uomo?
Siamo in un momento storico in cui i lavoratori autonomi stanno venendo letteralmente falcidiati, la piccolissima impresa è ridotta all’auto-sfruttamento intensivo e i lavoratori dipendenti privati sono schiavizzati come non succedeva da fine Ottocento. Non è forse questo il momento di incontrarsi e dialogare, dipendenti e autonomi, per rivolgerci insieme contro il vero nemico? Contro la grande e grandissima proprietà, le multinazionali, i poteri finanziario-assicurativi, i colossi di hi-tech e big-tech. Non è giunto il tempo di sabotare gioiosamente tutti insieme i grandi magazzini, Amazon, le varie piattaforme on-line, i negozi di lusso, le grandi assicurazioni, l’e-banking, gli elaboratori di Big Data e le loro tentacolari ramificazioni in ogni più minuscolo anfratto delle nostre esistenze? Non sono forse questi i veri, infami nemici di tutti (compresi di quelli che ci lavorano)?
Dobbiamo distruggere ciò che dell’apparato tecnologico che ci domina non serve ai rapporti umani e alla sussistenza; distruggere tutto ciò che serve solo alla produzione di beni e bisogni che non sono nemmeno superflui, ma esplicitamente antagonisti rispetto al bisogni sociali fondamentali di un essere umano non-alienato (gioco, socialità, amicizia, famiglia, condivisione, eros). Persino l’idea di lusso può essere risignificata. Il lusso non ha sempre coinciso con il possesso di beni preziosi e con la fruizione di servizi di pregio: il lusso nella storia umana è l’ostentazione, lo sperpero, il sacrificio di un sovrappiù di ricchezza e potenza che ha come effetto l’elevamento del rango sociale di colui/colei che sperpera.
L’erotismo, la festa, la condivisione della cultura, il confronto libero con gli altri, il confronto della propria cultura con quella altrui: questi sono i bisogni sociali fondamentali che le macchine stanno distruggendo. Per quale motivo non dovremmo allora considerare noi la possibilità di distruggerle? Distruggerle, sì. Distruggerle senza temere che poi non ci sarà lavoro. Ci sarà eccome. Distruggere fisicamente – come ci ha insegnato la poetica serie Mr. Robot – le buone vecchie macchine, gli hardware e i server, che fanno funzionare questa tela di ragno che chiamiamo economia digitale. Ma prima di tutto – riprendendo la lezione di Matrix e Fight Club – distruggere la macchina in cui queste macchine ci stanno trasformando. Distruggere l’automa che stiamo diventando, strappare i circuiti psico-politici che stanno trasformando il nostro eros, i nostro modo di stare con gli altri, il nostro cervello in qualcosa di essenzialmente calcolato e calcolabile.
Amo colui che vive per conoscere e che vuole conoscere, affinchè un giorno viva il superuomo. Poiché così egli vuole la propria distruzione.
Amo colui che lavora e inventa, per edificare una casa al superuomo e preparare a lui la terra, gli animali e le piante: giacchè così egli vuole la propria distruzione.Amo l’anima traboccante di colui che dimentica se stesso e tutte le cose che sono in lui: così tutte le cose cooperano alla sua distruzione.
Amo chi è libero spirito e libero cuore: perché la sua mente non è altro che viscere del suo cuore, … ma il cuore già lo spinge alla rovina.(F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra)
Non toccare quella macchina… O ti uccido!
Abbiamo bisogno come l’aria di riconoscerci amici in una battaglia, indipendentemente dalle nostre storie personali, da chi abbiamo votato in passato, da quello che pensiamo sui diritti civili o su come gestire i flussi migratori. Dobbiamo agire, dobbiamo unirci. La battaglia fisica, mentale e collettiva contro lo sfruttamento è – dall’inizio della storia operaia – la battaglia contro le macchine e contro la loro proprietà privata.
Il 27 febbraio 1812 la Camera dei comuni ratifica il Frame Breaking Bill, che prevede la pena di morte per chiunque si macchi della distruzione di telai meccanici (frames). Lord Byron, niente meno, scherzi della Storia, è l’unico membro del parlamento britannico a levare una voce contraria. Nello stesso periodo in cui, seguendo la lezione di Foucault, le forme di coercizione e repressione vengono interamente assorbite dallo Stato, questo Stato già non è più altro che un mero strumento strategico nelle mani della classe capitalista in ascesa.
Questo nuovo Stato etico borghese – che Marx soli trent’anni dopo in Per la critica della filosofia del diritto di Hegel identificherà come lo strumento fondamentale attraverso cui è divenuto possibile applicare capillarmente la “seconda natura” capitalista a tutti i cittadini – equipara nel 1812 la distruzione di una macchina all’omicidio, allo stupro, all’altro tradimento. La Camera dei Comuni sancisce che la macchina è un bene fondamentale, che attentare alla sua “vita” è punibile con la morte.
La lotta di classe come guerra civile permanente non è un sogno marxista o foucaultiano: è l’incubo di tutti coloro che stanno per svegliarsi di colpo in questa guerra, in questo specchio, nei profondi sconvolgimenti che ci attendono, senza sapere ancora da che parte stanno.
Uno stralcio dei versi di Lord Byron in onore dei luddisti:
Alcuni hanno pensato, senza dubbio, che è scioccante
mentre la fame chiama e la povertà geme
che la vita sia valutata ancor meno di una merce
E che rompere un telaio
conduca a [farsi] rompere le ossa.